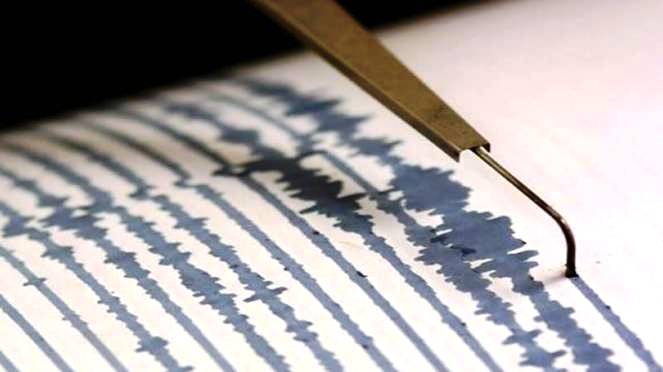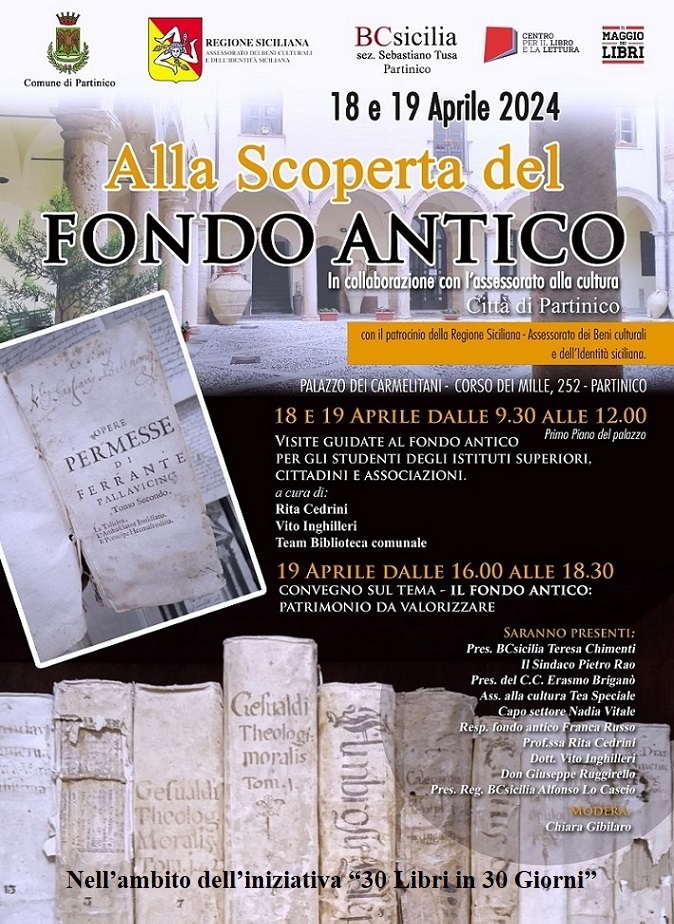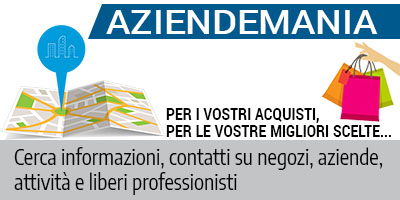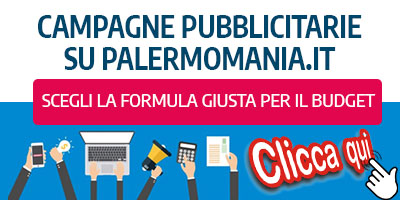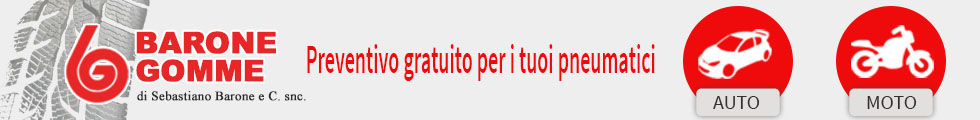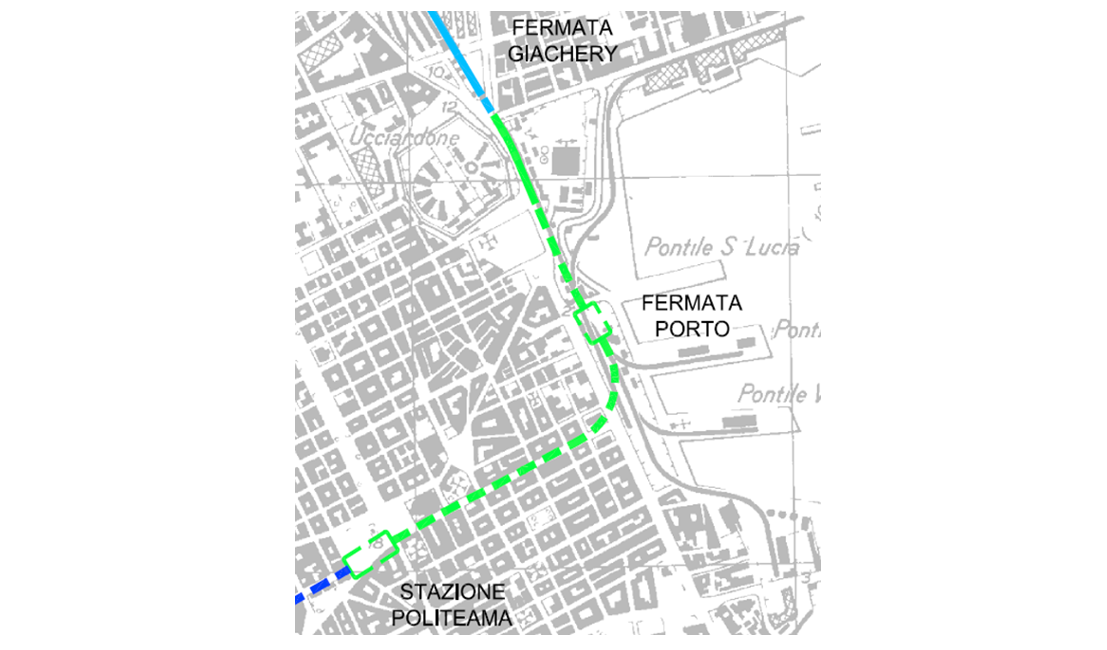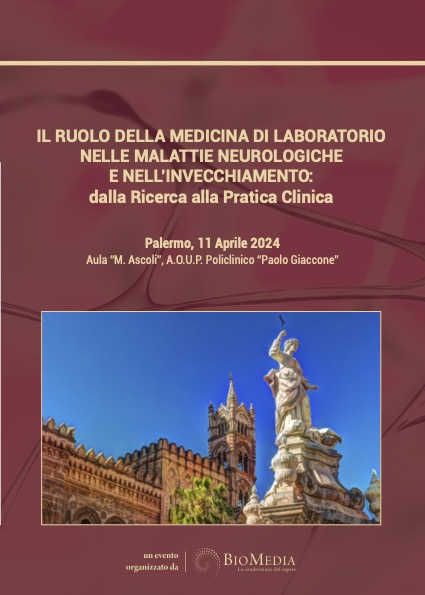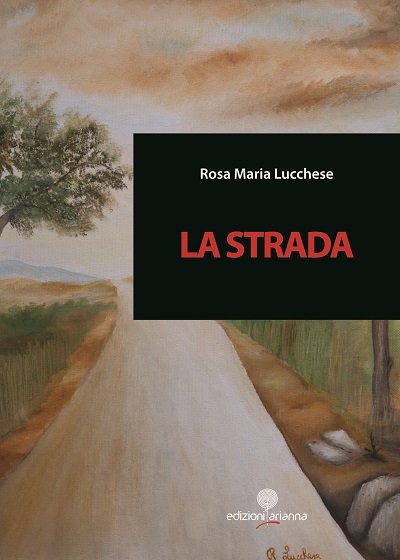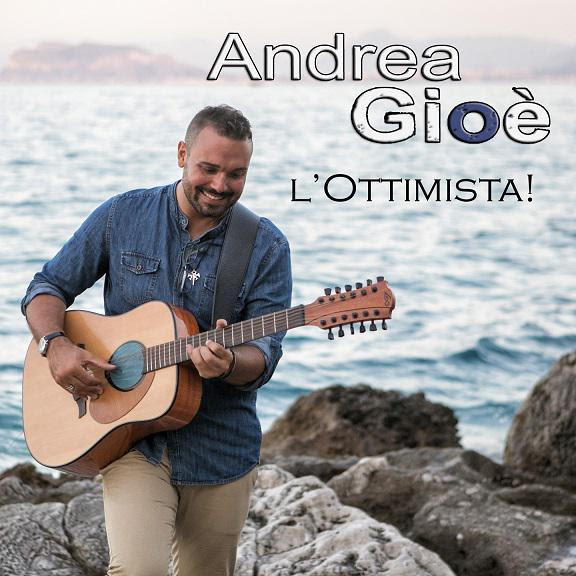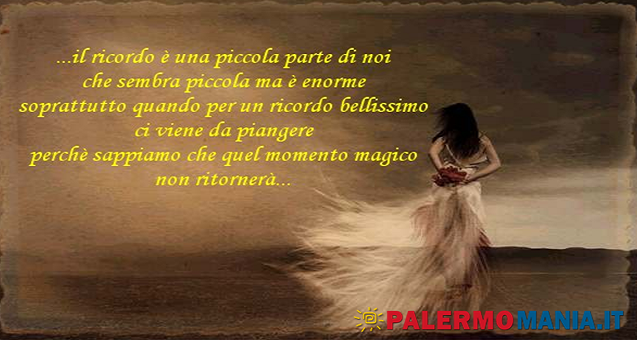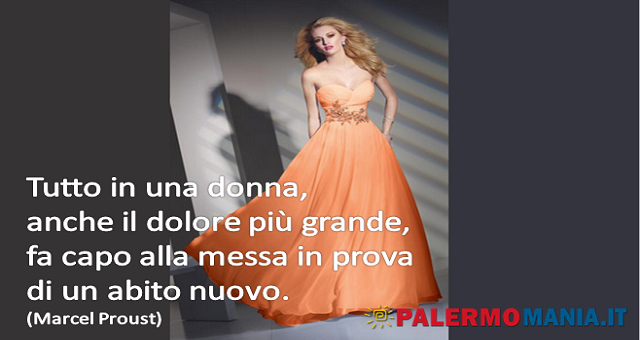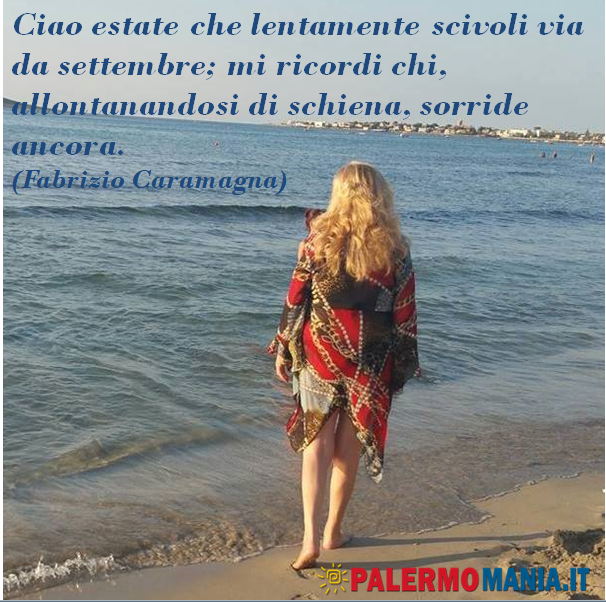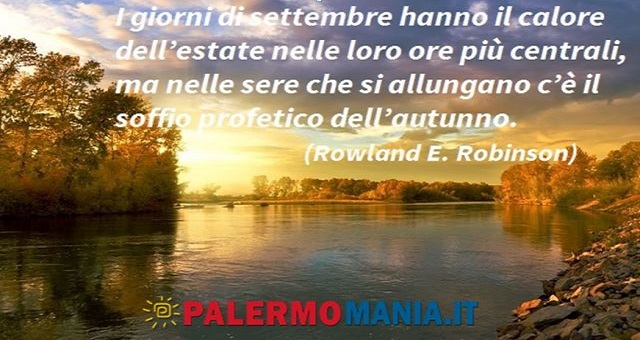Cronaca e politica
Comunicati - Eventi
Vita delle aziende
Foto dei lettori
Gli scatti più belli di Palermo, dei vostri viaggi in Sicilia o nei luoghi più lontani, o anche dal balcone di casa.
Inviateci le vostre foto cliccando qui!
Economia e lavoro
Approfondimenti
Opinioni a confronto
Scuola
Lifestyle - Mondo
Festival di Sanremo 2024
Sport
Ambiente, Scienza & Tecnologia
Salute e benessere
Meteo
Storie, origini e tradizioni
'Figlia di un dio burlone' di Anna Mauro
L' A. P. S. "RADICI DI SOLE" presenta "Figlia di un Dio Burlone" di Anna Mauro. Responsabile di produzione Sergio Pochini
Amore imperituro nel 'Tunnel dell'eternità' di Anna Mauro
Al Nuovo Teatro Orione Palermo L' A. P. S "RADICI DI SOLE", il 12 dicembre ha ripresentato "Il Tunnel dell'eternità" con l"inappuntabile regia di Anna Mauro...
Anniversario morte Piero Juvara, sensibile artista
Da un anno ci ha lasciati il poliedrico sensibile artista, poeta, scrittore, saggista Piero Juvara...
Dalle rubriche
- Musica e Teatro
- Angolo della lettura
- Poesie - Dediche
Multimedia
Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, cerimonia illuminazione di Palazzo Chigi