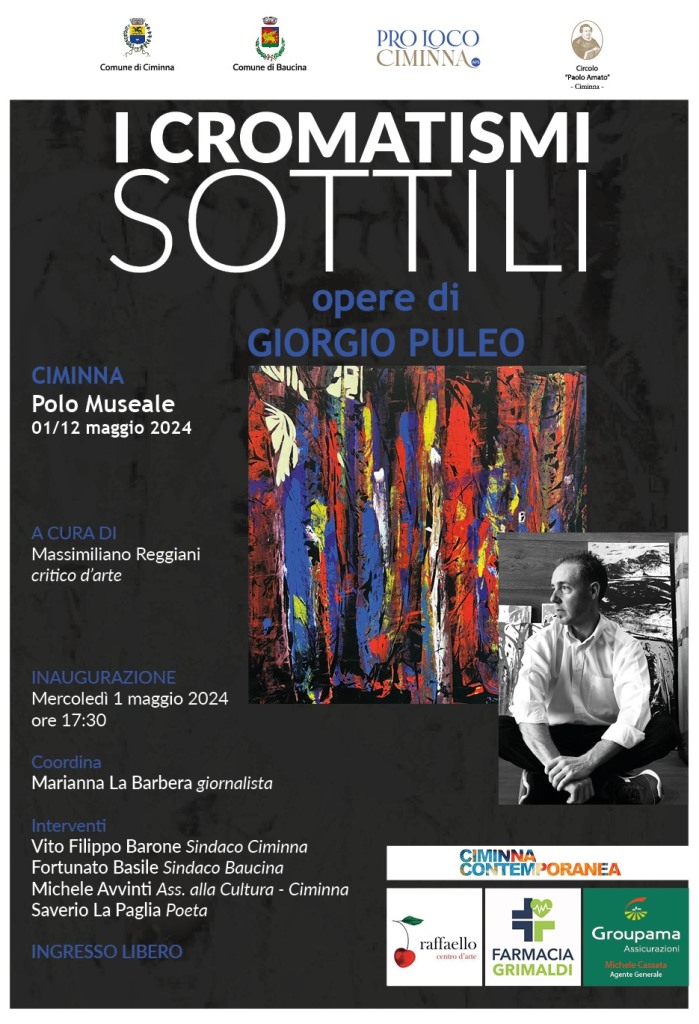Storie, origini e tradizioni
Santa Lucia
13 dicembre Santa Lucia. Culto e tradizioni
Il 13 dicembre ricorre la festa in onore di Santa Lucia, patrona della cittą di Siracusa. Particolarmente sentita in tutta la Sicilia, questa festivitą rientra nell'ambito dei festeggiamenti per il Natale.

La storia di Lucia, divenuta Santa, è davvero straordinaria.
Lucia era una ragazza cristiana, di famiglia benestante, nata a Siracusa intorno all’anno 281, fidanzata con un giovane concittadino. Orfana di padre, era molto affezionata alla madre Eutichia, che la educò ad una autentica fede cristiana. Durante un pellegrinaggio sulla tomba di Sant’Agata per implorare la guarigione della madre, in uno stato di estasi, le apparve la Santa Catanese, che le profetizzò il martirio. Nello stesso momento Eutichia guarì dalla grave forma di emorragia di cui soffriva da lungo tempo.
Tornata a Siracusa, ancor più forte nella fede in Gesù Cristo, decise di votarsi completamente a Lui, rinunciando al matrimonio e ai beni che possedeva, distribuendoli ai poveri della città.
Ciò non piacque al fidanzato che la denunciò al prefetto Pascasio: Lucia fu così arrestata con l’accusa di essere cristiana. Era il periodo in cui Diocleziano aveva scatenato l’ultima e più cruenta persecuzione contro i cristiani in tutto l’Impero Romano.
Durante il processo Lucia fu invitata ad abiurare la fede con lusinghe, minacce e torture, ma lei rimase irremovibile nella sua fede. La condanna a morte fu quindi inevitabile e Lucia venne decapitata (deiagulata) il 13 dicembre 304. Prima di morire profetizzò l’imminente caduta di Diocleziano e la pace per i cristiani in tutto l’impero.
Santa Lucia fu sepolta a Siracusa nelle catacombe che ancor oggi portano il suo nome e venne da subito venerata dai suoi concittadini quale patrona; sulla sua tomba venne edificata una chiesa, meta di numerosi pellegrinaggi. La più antica testimonianza archeologica del suo culto è “l’iscrizione di Euskia”, trovata a Siracusa nelle catacombe di San Giovanni e risalente alla fine del 4° secolo, lo stesso del martirio.
Il culto si espanse rapidamente in tutta la cristianità, come succedeva per i santi più popolari e amati. Nel 6° secolo vi erano già chiese, oratori, monasteri a lei dedicati anche a Roma e Ravenna, papa Gregorio Magno introdusse il nome di Santa Lucia nel Canone Romano e le consacrò una cappella nella basilica di San Pietro. La diffusione del culto ebbe così definitivo impulso e raggiunse ogni paese d’Europa, sia di oriente che di occidente.
 Il nome Lucia, dalla radice latina lux, lucis, fa riferimento alla luce, e venne via via a significare segno e promessa di luce spirituale: per questo Santa Lucia è la Patrona dei ciechi e degli oculisti, invocata per la protezione della vista e nelle malattie degli occhi.
Il nome Lucia, dalla radice latina lux, lucis, fa riferimento alla luce, e venne via via a significare segno e promessa di luce spirituale: per questo Santa Lucia è la Patrona dei ciechi e degli oculisti, invocata per la protezione della vista e nelle malattie degli occhi.
Il suo corpo rimase nelle catacombe di Siracusa fino al 1039, quando venne trasferito a Costantinopoli per proteggerlo dai Saraceni. Durante la crociata del 1204 i Veneziani lo trasportarono nel monastero di San Giorgio a Venezia ed elessero Santa Lucia co-patrona della città; le dedicarono successivamente una grande chiesa dove il corpo fu conservato fino al 1863, quando questa venne demolita per far posto alla stazione ferroviaria (che per questo si chiama Santa Lucia); il corpo fu trasferito nella chiesa dei Santi Geremia e Lucia, dove è conservato tutt’oggi, incorrotto.
Reliquie del corpo della Santa si trovano in molte città d’Italia, fra cui Siracusa, e d’Europa, fra cui Metz, in Lorena, fatto che spiega la diffusione del culto nei paesi nordici. Una reliquia si trova anche nella chiesa di Santa Lucia Extra in Verona. Due piccole reliquie, donate dal Patriarca di Venezia, si trovano dal 2002 nella chiesa di Santa Lucia eretta presso il Centro Ragazzi Ciechi “Kekeli Neva” di Togoville in Togo.
A Palermo, in questo giorno in cui si celebra la Vergine siracusana, si ricorda un vetusto avvenimento, che la Santa implorata dai palermitani esaudì facendo arrivare nel porto un bastimento carico di grano.
I palermitani stretti nella morsa della fame da diversi mesi di carestia, non raccolsero il grano per farne farina, ma lo bollirono, per sfamarsi in minor tempo, aggiungendogli soltanto un filo d’olio, creando così la “cuccia”.
Da quella volta i palermitani specialmente in ambito popolare, ogni anno per devozione ricordano solennemente l’evento, rigorosamente ricorrono all’astensione per l’intera giornata dal consumare farinacei, sia pane che pasta, si preferisce mangiare riso, legumi e verdure, questi ultimi due alimenti ci riferisce il Pitrè anticamente in questo giorno erano le ragazze palermitane che per venerazione se ne cibavano e non doveva mancare la “cuccia”, questa tradizione era dovuta alla preservazione degli occhi incantevoli.
Le tradizioni siciliane legate al 13 dicembre
I palermitani sono soliti ricordare un vecchio motto: “Santa Lucia, pani vurria, pani nu nn’haiu, accussi mi staju". All’occasione quasi tutti i panifici della città rimangono chiusi e, a predominare sul territorio rimangono le numerose friggitorie sia quelle stabili che quelle ambulanti che vendono “panelle di ceci” e di “crocchè”. E’ praticamente il loro giorno trionfale e, un tempo, si facevano soltanto nei giorni che precedevano e seguivano questa festività e, nelle molteplici pasticcerie.
Quest’ultime, dai locali monasteri hanno tramandato l’uso di utilizzare l’antica “cuccia” che condita con crema di ricotta e cannella o con scaglie di cioccolata, si è trasformata in uno squisito dolce che viene prodotto solo esclusivamente il tredici dicembre.
Dolce da gustare dopo una gran scorpacciata di “arancine” realizzate con il classico ingrediente a base di riso e, principalmente farcite da un concentrato di ragù con carne tritata e pisellini.
A pranzo solitamente i palermitani per non mangiare la pasta si rifanno al riso che viene consumato a “minestra” con l’associazione di “sparaccieddi”, che comunemente gli italici chiamano broccoletti o “riso alla palermitana” dove il “timballo” è riempito da melanzane che la fanno da padrone, ma il periodo non sempre è favorevole, alcuni ricorrono a quelle conservate o quelle che oggi vengono coltivate nelle serre.
Il riso a volte e anche l’ingrediente principale per preparare il “grattò”, un timballo farcito, ma a Palermo da antica data, lo sformato è costituito da patate bollite e rese a “purèa” con l’inserimento di caciocavallo o tuma, associate a insaccati locali.
Anche le patate hanno un ruolo importante in questa giornata, esse dopo essere preparate a “purèa” con l’aggiunta di ingredienti poveri si ottengono le “crocchè”, ma è la patata bollita che solitamente viene comprata dal fruttivendoli ad essere allestita all’insalata.
Le arancine
.gif) Le arancine a Palermo, e in genere nella Sicilia occidentale, sono di forma rotonda, mentre in quella orientale hanno forma allungata e si chiamano arancini; tuttavia, a prescindere dalla forma, dal nome o dalle tante varianti che ogni parte dell’Isola offre, queste bionde e inconfondibili golosità , rappresentano una delle leccornie più rappresentative della Sicilia.
Le arancine a Palermo, e in genere nella Sicilia occidentale, sono di forma rotonda, mentre in quella orientale hanno forma allungata e si chiamano arancini; tuttavia, a prescindere dalla forma, dal nome o dalle tante varianti che ogni parte dell’Isola offre, queste bionde e inconfondibili golosità , rappresentano una delle leccornie più rappresentative della Sicilia.
L’arancina esprime il massimo della civiltà della nostra isola: pensare a portarsi dietro qualcosa di cotto da casa proprio quando dal focolare domestico si è lontani, attiene ai puri piaceri dello spirito. Basta pensare a quei “mischini” che debbono accontentarsi di un anaffettivo panino il quale, anche se contiene una salsiccia o una polpetta, è legato sempre e soltanto all’emergenza.
Si racconta che fu l’emiro Ibn At Timnah ad inventare il “timballo di riso” o di pasta; pare che se lo portasse appresso quando andava a caccia. Una trovata geniale: il riso profumato di zafferano e teneri piselli, con tanti pezzetti di carne, fu manipolato in modo da farne una palla grossa quanto un’arancia che, impanata e fritta, resisteva superbamente al trasporto.
Pare che il risotto alla milanese altro non fosse che un’arancina che non riuscì a prendere la giusta forma per la differente qualità del riso lombardo e così, finì disfatta su un piatto, diventando un semplice risotto.
La ricetta delle arancine. Cuocere il risotto circa dodici ore prima di realizzare le arancine (deve essere freddo, perché per la buona riuscita delle arancine l’impasto deve essere abbastanza duro e appiccicoso).
Preparare il brodo lo nel quale scioglieremo lo zafferano. In un tegame capiente, fare appassire la cipolla tagliata finemente (non deve imbiondire), aggiungere il riso e farlo tostare quindi, sempre mescolando, aggiungere il brodo, ben caldo, poco per volta e portare il riso a cottura, scendere dal fuoco e amalgamarvi il parmigiano grattugiato e versarlo in un piatto grande e farlo raffreddare. Prendere una cucchiaiata di riso e metterla sul palmo della mano in modo da formare un incavo dove metteremo un cucchiaio di ragù e, al centro, un cubetto di primosale. Prendere un’altra cucchiaiata di riso e ricoprire molto bene il ragù, facendo attenzione a non farlo fuoriuscire. Formare l’arancina stringendo questo composto con le mani in modo da compattarlo. Passare a pangrattato sempre compattando l’arancina e mettere da parte. Procedere fin quando si esauriscono gli ingredienti.
In abbondante olio bollente friggere le arancine fin quando non saranno ben dorate (il risultato migliore si ottiene con una friggitrice).
Le immancabili panelle
.jpg) Le panelle si preparano facendo sciogliere la farina di ceci in acqua con sale e prezzemolo.
Le panelle si preparano facendo sciogliere la farina di ceci in acqua con sale e prezzemolo.
Poi si pone il recipiente sul fuoco e si rimescola continuamente sino ad ottenere una pasta piuttosto solida (tipo polenta) che, ancora calda, si spalma in apposite formelle di legno di faggio dalla canonica forma rettangolare.
Il Pitrè ci riferisce che in passato questi rilievi avevano differenti forme tra cui, più frequente, quella di pesce. I “i pisci-panelli”, così le chiamavano i più indigenti che, mangiandole, s’illudevano di mangiare frittura di pesce, allora troppo costosa.
Arrivano ben calde e gonfie sul bancone, dove sono adagiate in un ripiano d’alluminio bucherellato per permettere all’olio di scolare, e in men che non si dica vanno a riempire la pagnottella che sarà tagliata a metà, aperta a mo’ di cerniera, e riempita.
La cuccia
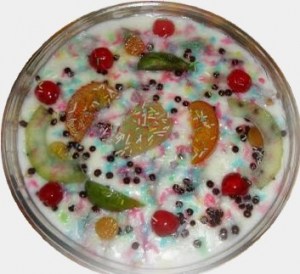 Il nome “cuccia” deriva da un trascinamento del sostantivo “cocciu” cioè chicco, o dal verbo “cucciari”, vale a dire mangiare un chicco alla volta.
Il nome “cuccia” deriva da un trascinamento del sostantivo “cocciu” cioè chicco, o dal verbo “cucciari”, vale a dire mangiare un chicco alla volta.
Difatti la sua preparazione è quasi un rito nelle famiglie siciliane e palermitane in particolare, una antica consuetudine che ci perviene dall’ormai scomparso mondo contadino che in periodo di mietitura, i chicci di grano raccolti venivano lessati e mangiati sul posto nei momenti di pausa.
Una pietanza sicuramente molto antica che i nostri conquistatori musulmani ci hanno tramandato e, se facessimo un confronto con alcune città arabe come: Tunisi o città del Cairo dove è ancora fattibile assaggiare, ancora in data odierna una pietanza Kech o Kesh, consistente da grano bollito addolcito da latte di pecora o di cammello associato a vaniglia e cannella.
Bisogna ammollare il frumento per tre giorni in acqua fredda e cambiando questa continuamente, prima di cucinarlo.
La sera prima della festa, finalmente si metterà il frumento a cuocere in un tegame, coperto d’acqua con un pizzico appena di sale. Scolato bene verrà addolcito con crema di ricotta, scaglie di cioccolata e frutta candita a pezzetti e la scorretta d’arancia o con “mouse” di cioccolata oppure con una crema di latte, così preparata veniva offerta a chi fa la devozione alla Santa, ai familiari, ad amici e ai vicini di casa.
Anticamente quando era semplicemente lessata, le briciole si lasciavano sui tetti per essere catturati dagli uccellini. In questa tipo di manicaretto si elogia la qualità di questo cereale: il frumento ed i suoi derivati che negli antichi cerimonie ancestrale c’è anche quello della “cuccia”.
© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°
Lascia un tuo commento
Questo articolo ha ricevuto
Ultimora by Adnkronos
-

Israele, media: "Possibile invasione Rafah senza accordo entro 72 ore"
Pubblicata il 30-04-2024 alle ore 08:27
-

Sanremo 2025, Carlo Conti sempre più vicino? Gli indizi
Pubblicata il 30-04-2024 alle ore 08:05
-

Padova, ritrovata la 15enne scomparsa da casa da giorni
Pubblicata il 30-04-2024 alle ore 07:47
-

Isola dei famosi, eliminazione e video Francesco Benigno: cosa è successo nell'ultima puntata
Pubblicata il 30-04-2024 alle ore 07:40
-

"Ucraina entrerà nella Nato", la promessa di Stoltenberg a Zelensky
Pubblicata il 30-04-2024 alle ore 07:01
Approfondimenti
Opinioni a confronto
Articoli pił letti
- Oggi
- Settimana
- Mese